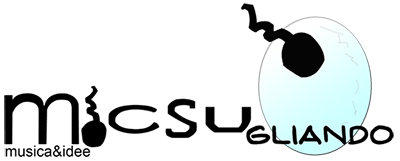Dallo stretto passaggio sotto la stazione arrivava una luce lontana, screziata di verde – foglie e alberi sempre più grandi, sempre più grandi – finché sopraggiunsero: l’argine, i pioppi maestosi mossi dal vento. E giù, invisibile, lo scorrere dell’acqua chiara di luglio, moscerini e libellule, i tonfi sordi della pescaia a destra, la roccia di Capraia a sinistra. In mezzo scorreva il fiume, clemente gigante placido tenero e magro, abituato alle coccole estive del muschio e dei germani reali.
Dallo stretto passaggio sotto la stazione arrivava una luce lontana, screziata di verde – foglie e alberi sempre più grandi, sempre più grandi – finché sopraggiunsero: l’argine, i pioppi maestosi mossi dal vento. E giù, invisibile, lo scorrere dell’acqua chiara di luglio, moscerini e libellule, i tonfi sordi della pescaia a destra, la roccia di Capraia a sinistra. In mezzo scorreva il fiume, clemente gigante placido tenero e magro, abituato alle coccole estive del muschio e dei germani reali.
Il ragazzo scese, abbandonando i campi, guidato dal fischio particolarissimo che c’era nell’aria. Non poteva confonderlo. Sotto i piedi, una macchia di vegetazione spontanea blu, verde e marrone, di foglie e insetti intricati al suo passaggio, tronchi assopiti e fastidiosa ortica pruriginosa, che gli graffiava gli stinchi e i polpacci. La via era stretta e ripida, tagliata di fresco: niente aveva potuto scorgere con chiarezza, se non la sabbia a cui i passi e il sentiero lo portavano, le macchie gialle di tarassaco e infine lui, il fiore più perfetto della spiaggia. Si fermò a pochi centimetri, sperando di poterlo conoscere. Il fiore, però, rimase sempre sul vago: aveva intorno delle foglie di un verde profondo, ma di una forma particolare, di tanto in tanto appuntite; e lui, anche lui aveva cinque punte, pareva una stella viola chiarissimo, con un cuore più oscuro di nero e di giallo. Non si poteva sapere altro: il fiore taceva come suo padre, che, con un gesto semplice, lo salutò badando alle canne e ai galleggianti, invitandolo al raccoglimento della messa solenne sul limo dell’Arno, a cui aveva assistito innumerevoli volte.
Stava così, sulla spiaggia fredda, senza niente da dire. Pensava al passato, e sentiva di non star facendo niente di male: era l’acqua che ce lo spingeva, che lo catturava in un vortice di ricordi, non suoi, mai suoi, ma del fiume, dei riflessi, del paese tutto. C’erano voci che si rincorrevano giù dagli orti e sul muschio marcio, e traballando percorrevano i rami degli alberi sull’acqua – verde contro verde, azzurro contro azzurro, per sempre e sempre – fino ad approdare all’argine opposto, sulla parete scoscesa e secca, tra i nidi dei passerotti e poi su. Là, sulla collina mangiata dall’erba e dalle ginestre, stava la voce antica: Amabile guadava ancora l’Arno col barchino, dalla sponda tedesca a quella americana, cercando la salvezza. E riusciva: sì, riusciva, si inerpicava fra le piante e iniziava a correre verso il suo destino. Il suo destino era una mina che non tranciava né gambe né braccia, né sfigurava il bel corpo di donna, ma entrava come uno spillo all’altezza della tempia, lasciandola esanime al suolo. Di lei, sulla collina, rimaneva una lapide ignota – mangiata dall’erba e dalle ginestre.
Una voce più nuova si faceva strada alle sue spalle, da sinistra: era Santina, un’altra donna del fiume. Raccoglieva fagiolini di novembre, sotto l’acqua battente e sul piccolo ponte scoperto. Accucciata sotto il suo ombrello – nero – il vento se la portava via, e lei scompariva tra i rami e i gorghi di fango. Il ragazzo vedeva allora centinaia di voci, come fantasmi, che sciamavano dall’argine alto fin verso la sua spiaggia, in processione incessante, gridando e piangendo per lei: c’erano i vigili del fuoco coi loro barchini, che sondavano le correnti; c’erano le indovine, munite di bastoncini, che sibilavano: è qui, è qui; c’era il povero figlio da poco sposato che girava – come un segugio – fra l’erba, digrignando i denti al grande fiume e schiumando rabbia alla sorte. C’era, infine, quel mucchietto di fagiolini rimasto a ballonzolare sul ponte, che significava la fine. Restava così a San Rossore: Santina nuda e leggera, impigliata con altro ciarpame e stracci della prossima piena – attesa e tremenda – e la riportavano a casa.
All’improvviso, le due sponde tacevano: i tempi, una volta presenti e vivi, erano passati e morti. Poi, d’un tratto, accadde: una libellula annaspò al suo fianco, luminosa sotto la luce del sole, e dopo molti tentativi decise infine di posarsi, aggraziata come una dama. In quel preciso momento, suo padre lo riscosse da quel sogno iridescente – verde contro verde, azzurro contro azzurro, per sempre e sempre – e gli indicò col braccio la volpe. Era sull’argine opposto insieme ai due cuccioli, e velocemente correva fra le piante, quasi invisibile se non per la pelliccia rossa che, in lontananza, si dissolveva come gocce d’acqua nell’atmosfera gialla e verde. Sì, c’erano ancora voci. L’ultima si alzava oltre la sua testa, un canto disperato dai polmoni del contadino chino sui pomodori – pittore, ti voglio parlare, mentre dipingi un altare – e un’altra, più vecchia, gli faceva eco, cercando con gli occhi e con la bocca la bella volpe scomparsa, e forse qualche carpa regina.
Altre voci senza parole spezzavano il silenzio: voci profonde di allegria, di rimpianto, di desideri, o di freschezza di bambini. Spezzavano il silenzio? Oh, ma non c’era silenzio: gli alberi frusciavano continuamente e l’acqua spezzata della pescaia mandava gorgogli. Sopra di loro, instancabili, le voci secolari gridavano più forte, e le foglie assolate e i petali di miriadi di fiori gettavano i loro colori nell’aria.
E se l’Arno fosse questo, se potessimo vedere questi fiori? Buon Ferragosto a tutti.