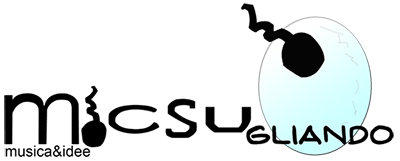Di solito eravamo in tre seduti sul muretto davanti alla chiesa picco-
la, nella piazza grande del paese, nelle notti appiccicose dell’estate
a fantasticare fino a tardi. Allora i lampioni elettrici erano più radi,
la luce meno accecante, non c’èra ancora tutto quell’inquinamento
luminoso frutto di scellerate scelte governative, arrivato molti anni
più tardi. Alle spalle le luci sparpagliate della Valdera, come se una
mano gigantesca le avesse gettate simili a dadi luccicanti, alla rinfusa
a disporsi casualmente su avvallamenti e pendii.
Mentre l’estate apre le finestre e libera voci e musiche lontane, passava-
mo ore a parlare della nostra comune passione, e paragoni e confronti
si sprecavano ad ogni parola, convinti ognuno di essere migliore degli
altri ed egli solo unto dal signore per un radioso destino che lo avreb-
be portato alla fama e alla ricchezza. I più grandi nomi della storia
dell’arte divenivano familiari, Cezanne, Wan Ghog, Gaugain, Picasso,
si facevano puri e semplici colleghi, ai quali sembrava avessimo par-
lato decine o centinaia di volte, discusso e partecipato con loro, allo
sviluppo delle più importanti correnti artistiche degli ultimi due secoli.
In realtà, anche se la nostra passione per la pittura era davvero gran-
de e, almeno per quanto mi riguarda, lo sarebbe diventata sempre di
più, gli artisti famosi li avevamo conosciuti solo sui libri di storia, e
ognuno di noi, pur dedicandosi nel tempo libero alla pittura, aveva per
tirare avanti un ben differente lavoro.
Picasso era il più menzionato, il più osannato dai miei due amici e
colleghi pittori, sappiamo tutti quanto questo artista sia stato il più
precocemente ricco e famoso pittore della storia, quello di cui tutti
avrebbero voluto eguagliare il destino.
Per me non è mai stato così, non ho mai pensato a Picasso come ad
un grande artista, certamente pittore di ottima scuola, ma per il resto
nel migliore dei casi, ha semplicemente coinciso con una negativa
evoluzione che il mondo stava mettendo in atto e al quale egli ha dato
una spinta ulteriore.
Anche la definizione “Genio predatore”, non mi è mai piaciuta, se-
guendo questo concetto avremmo dovuto finire ammettendo che
l’americano che rubò l’invenzione del telefono all’italiano Meucci era
un genio. Io ritengo che questo grande, conosciutissimo artista, abbia
innescato quel processo mentale che ha portato a pensare la furbizia
un valore positivo, mentre, contrariamente a questa idea a mio avviso
la furbizia è in antitesi, si è furbi se si è ingannato qualcuno. Anche se
da bambini, con un qualche espediente, si è distolto mezza caramella
ad un altro bambino, è chiaro che la caramella era mezza, ma il prin-
cipio infranto era intero.
Sventare qualcosa messo in atto contro di noi è essere attenti, è diverso.
1
C’è ancora da dire che Picasso è stato il primo ad abbandonare la ma-
nualità, quella di dipingere come i bambini è una enorme castroneria
che ha permesso ad un numero infinito di deficienti di infilarsi trasver-
salmente nel mondo dell’arte, incentivati da un mercato che sempre di
più ha richiesto costi minori per maggiore guadagno spingendo ad una
sempre più elevata velocità esecutiva. Allontanarsi progressivamente
dalla manualità avrebbe finito coll’inquinare le coscienze professionali
e, in definitiva, l’inizio di una immensa forza disgregatrice che avreb-
be in seguito annientato e distrutto completamente il senso civico.
Naturalmente la classe politica si era resa conto che il mondo dell’arte
le stava facendo un enorme favore, avvallando questa tendenza è sta-
to sufficiente seminare nei luoghi pubblici opere sempre più distanti
dall’impegno manuale, avulse da qualunque riferimento col passato,
per ottenere il loro grande obbiettivo, privare le masse della sola arma
che possedessero. Sviscerarle completamente del senso critico.
La televisione, non tutta, aveva fatto il resto. Il disimpegno era diven-
tato cultura.
Mentre la classe dirigente imputridiva nella propria vorace verace avi-
dità, la gente affondava sommersa nell’inevitabile rincoglionimento
totale.
Non mi è mai interessato Picasso. Io amavo Klimt, Gustav Klimt, an-
che se allora non avevo mai visto una sua opera dal vero, come poi
ebbi ad avere occasione a Vienna o a Parigi, al di fuori dei grandi del
rinascimento, consideravo Klimt il più fantastico pittore del passato,
per la sua sobria raffinata eleganza, per la sua assoluta padronanza
della tecnica anche su enormi superfici, ritenevo e ritengo Klimt un
insuperabile talento che mai ha avuto negative ripercussioni sociali.
Del resto c’è un parallelo anche con altre espressioni d’arte. Non amo
assolutamente quei comici di teatro o cabaret che sbrodolano il co-
pione, talvolta incespicando su loro incomprensibili neologismi, pur
carichi di grande simpatia, non hanno quella padronanza linguistica
pulita, ordinata, precisa, affilata e tagliente come la lama di un rasoio,
come per esempio sa fare il grande Kammerle, senza che per questo
venga a mancargli la propria innata simpatia.
Talento e dedizione.
Uno in particolare, tra i miei amici pittori era un autentico sperimen-
tatore, spiritualmente legato alle più audaci transavanguardie artisti-
che dell’epoca, non si lasciava sfuggire occasione per sventolare, non
senza enfatica irruenza, la sua totale estraneità all’abilità manuale; “
Io non so disegnare!” Confessava candidamente “c’è una enorme dif-
ferenza tra il pittore e l’artista!” Naturalmente il pittore ero io, io che
avevo fatto e stavo facendo un percorso del tutto tradizionale. Io che
da ragazzo avevo dipinto le galline o la mucca della nonna, i paesaggi
della nostra campagna, le strade alberate o il fagiano e il fucile arte-
mente disposti su di un tavolo. Io che in quel periodo ero immerso in
una sorta di pittura iperrealista, che sia pure di impostazione surreale,
2
il mio lavoro, costringeva la gente ad avvicinarsi al quadro, carezzarne
la superficie, cercando di capire se si trattasse di pittura o di fotografie
appiccicate sulla tela. Io che su vecchi opuscoli avevo imparato che il
blu di prussia tende nel tempo a diventare nero, e che si ovvia all’in-
conveniente mischiandolo con del blu cobalto. Ma ad onor del vero,
io, seppur della pittura ne avessi imparato le note, mi sono sempre da
sempre considerato un semplice produttore di immagini. Neanche un
pittore, e men che meno un artista. L’artista era lui, lui che per settima-
ne ammucchiava sopra di un foglio, uno accanto all’altro un quadra-
tino e un cerchio, un rettangolino e un triangolo, un ghirigoro ed una
spirale, una lineetta e un punto. Il tutto con quei pennarelli di cartole-
ria, dei quali ben sapevo e cercavo di comunicare le loro evanescenti
qualità, redarguito del fatto che noi pittori davamo troppa importanza
alle questioni tecniche.
Una volta l’ho visto addirittura lavorare per mesi ad una minuziosa,
grandissima tela, e solo quando il dipinto asciugatosi si stava staccan-
do dal supporto, mi sono reso conto che per tanto tempo aveva lavora-
to con dei colori acrilici su di un fondo eseguito con i colori all’olio.
E averglielo fatto notare fu motivo di un focoso diverbio.
Ma questo non ha mai guastato veramente la nostra annosa amicizia.
In un’altra occasione il mio amico artista, fotocopia fedele di tanti altri
suoi cloni conosciuti dagli anni settanta ad oggi, mi diede ulteriore
modo di elaborare i miei futuri pensieri su un certo tipo di arte.
Credo che questo fosse qualche anno più tardi dei tempi del muretto
davanti alla chiesa, ora mi rendo conto di come fosse possibile per le
persone anziane equivocare tra un decennio e l’altro, tante volte avevo
sentito discussioni che ritenevo assurde, tra chi asseriva un certo fatto
accaduto negli anni venti e chi al contrario sosteneva lo stesso avveni-
mento dieci anni più tardi.
C’èra una festa in un paese vicino, un bel paesotto antico che si au-
toincensa essere città, del resto se a loro fa piacere definirsi così, non
esiste nessun valido motivo per contrariarli cosìcché facendo un re-
pentino passo indietro potremmo ricominciare dicendo che c’éra una
festa in una vicina città, ed il mio storico amico artista ed io, sapendo
di una esposizione di pittura organizzata dall’amministrazione locale,
decidemmo per una visita.
Eravamo in estate. Partimmo a cavallo di un mito, la Renault 4, anche
se, poiché ambedue possedevamo il medesimo modello di auto non
ricordo se fosse la mia o la sua. Io ero, se non ancora divorziato, cer-
tamente separato da alcuni anni, ma credo che egli, contrariamente ad
alcuni anni dopo, avesse ancora famiglia.
Insieme a noi viaggiavano le nostre differenti visioni pittoriche. Par-
lando, talvolta animatamente del più e del meno, pur mai riuscendo a
calcolare neanche in maniera approssimativa in quale misura si par-
lasse del più e in quale del meno, giungemmo, dopo aver scavalcato
un paio di versanti collinari, in vista della meta.
Non è mai facile trovare parcheggio in simili circostanze, ma con un
po’ di pazienza dopo aver girovagato per qualche chilometro, riuscim-
3
mo a trovare un posticino per la nostra auto.
Era circa metà pomeriggio, il mese di luglio, il periodo che amo di
più, quando il caldo si fa soffocante e assume connotazioni tropicali
quasi insopportabili. Presto ci rendemmo conto che la manifestazione
artistica si dislocava in tutto l’abitato, qui incontravamo, appoggiata
in un angolo una trave di ferro che ben poteva essere equivocata con
la dimenticanza di un qualche lavoratore dell’edilizia, poco più in là
una sfera grossotta, neanche nobilitata dal materiale utilizzato né dalle
dimensioni, ancora più in là, una enorme tela sulla quale velocissima-
mente abbozzata capeggiava il profilo di una mucca e ad appena due
metri di distanza, su di un’altra tela della m
edesima misura, il toro,
enorme e possente, tratteggiato con larghe, velocissime, abilissime li-
nee, guardava estasiato la sua amata.
Una mucca e un toro. Me lo immaginavo l’artista mentre spiegava ai
suoi interlocutori, alzando le braccia verso il cielo in uno sciamanico
gesto magnetizzante, che egli con quel favoloso dipinto, opera, fatico-
samente meditata negli anni, aveva compenetrato totalmente il segreto
dello yn e yan, il maschio e la femmina, che dalla creazione del mon-
do, sempre da sempre perpetuano il misterioso, ancestrale dono della
vita. Naturalmente guai chiedergli quale fosse questo segreto, avrebbe
continuato a sproloquiare sull’archetipo, il catartico, lo psicocinetico,
il prototipo, il fascino, le vibrazioni, soprattutto le vibrazioni.
Avevo notato che certe cose, quanto più fossero distanti dalla abilità
manuale e dall’impegno, quanto più il mio amico e la sua schiera di
cloni, le trovavano interessanti. Io molto più prosaicamente, pur senza
essere volgare esprimevo le mie convinzioni dichiarando apertamente
che per fare puttanate del genere mi sarebbe stato sufficente legarmi il
pennello alla fava. Mi si è sempre obiettato che l’importante era l’idea,
ma a nessuno ho mai sentito spiegare razionalmente di quale idea si
trattasse. Io invece cominciavo a darmi una spiegazione di quale fosse
l’idea fondamentale. Guadagnare sfruttando la ingenua credulità di
tanto avventato collezionismo, senza fare un cazzo.
Proseguimmo il nostro giro per la città, le opere che pur nel loro tenta-
tivo di ricerca e modernità, conservavano una traccia di evidente mae-
stria, erano dal mio esimio collega, liquidate distrattamente e con aria
di sufficienza, riconoscendo loro nel migliore dei casi una certa abilità
tecnica, ma quando si trattava di cose in cui l’impegno lavorativo era
totalmente assente, allora eravamo veramente davanti a qualcosa di
interessante. Ma il Gota dell’invenzione, la quint’essenza dell’arte, la
bellezza e purezza sconvolgente e assoluta, dovevamo ancora vederla.
C’è in quella città, più o meno in centro vicino alla chiesa e molto
probabilmente comunicante, un bellissimo antico loggiato e sotto a
quel loggiato c’è un cortile. Scendemmo le scale per accedere a co-
desto cortile, e non appena in fondo, vedemmo da lontano delle opere
pittoriche coloratissime.
Fu quella l’illuminazione, la folgorazione, quelle erano opere straor-
4
dinarie. E lo disse il mio amico, chiamando a testimone ogni sorta di
divinità, avvicinandosi ripetè più volte che quelle erano opere mera-
vigliose. Aveva avuto una ispirazione divina il mio esimio collega, in
quelle opere c’èra davvero dello straordinario, era l’età degli autori,
erano tutti disegni dei bambini della scuola materna. Il mio amico, ha
solo incarnato un’epoca.
Lenta la notte si avvicina e uccide
il giorno ogni volta che lo vede
ma il giorno é scaltro e quindi si allontana
per nascondersi dietro la collina
pazienza é quello che la notte pensa
domani sera tornerò di nuovo
e a volte, col favore delle nubi
le si fa appresso un poco più veloce
ma il giorno la conosce la sua voce
i chiassosi silensi che produce
e per quanto sia stata repentina
le sfugge ancora dietro la collina
poi si incammina e allora senza fretta
col cuore gonfio medita vendetta:
a correr sarai tu quand’é mattina
Notte di ferragosto…ma quale ferragosto! Eravamo ai primi di luglio e
la notte era caldissima, quel caldo torrido, appiccicoso, quel caldo che
ti fa sudare, senza un filo d’aria, se non quella afosa che ha portato il
vento dell’affrica.
In quel tempo, in un paesotto poco distante dalla cittadina che avevo
visitata il giorno precedente assieme al mio amico pittore, avevo una
compagna, e con lei avevamo deciso di fare un viaggetto e partire
molto presto al mattino. Durante il giorno avevo tirato a lucido la mia
erre quattro, cambiato l’olio, aggiunto l’acqua, guardato l’olio dei fre-
ni, gonfiato al punto giusto le gomme. Fatto valigia. Un po’ di calzini,
qualche mutanda, qualche maglietta della salute, camicie, pantaloni,
una maglia, ciabatte, scarpe, spazzolino, autan, il tutto gettato in qual-
che vecchia borsa in rigoroso disordine.
Notte fonda. Ma fonda eh! Il cervellino di cencio di cui la con me ava-
ra madre natura mi ha dotato inanellava fervidi balzani pensieri.
Avevo una vecchia camicia bianca neanche tanto vecchia. Decisi di
sacrificarla, passai tra le maniche una logora scopa di saggina, legai
al manico della scopa un grosso spago e schizzai la camicia con della
pittura rossa. La mia moderna opera d’arte, modello risorgimento era
pronta, mi armai di chiodi e martello e partii. Discesi un tratto di stra-
da, imboccai la provinciale per lasciarla qualche chilometro dopo di-
rigendomi verso est. Nella notte ci guidano le stelle, forte il cuore e il
braccio per colpir. Quante volte avevo sentito mio padre canticchiare
5
quel ritornello, memore e chissà, forse anche nostalgico di quelle sue
esperienze nelle langhe piemontesi. Ma io non avevo nessun atto eroi-
co o pericoloso da compiere. La notte scorreva tranquilla verso l’alba
di un lungo viaggio. La renotta quattrotta procedeva doverosamente
senza intoppi.
Arrivai sulla piazza degli archi. Silenzio. Assoluto silenzio. Piantai un
chiodo nello spazio tra due installazioni e vi appesi il mio improvvisato
lavoro, sotto, fissato con due chodini misi un talloncino di cartone
bianco la cui scritta recitava: “cruento epilogo di una camicia lisa”.
Rimontai in macchina guardando orgoglioso la mia opera, feci un
larghissimo giro, ancora insufficente per arrivare dalla mia amica
nell’orario che avevamo stabilito, dovetti ancora fermarmi ad aspetta-
re la luce del giorno, ma poi partimmo per rimanere in giro in Francia
Spagna e Portogallo quasi un mese.
Quando tornai ebbi a constatare divertito che il mio manufatto faceva
ancora bella mostra di se, nessuno si era reso conto che quella camicia
era stata messa abusivamente per burla.
I miei dubbi su certa arte moderna ingigantivano.
Qualche anno dopo vivevo, insieme alla mia compagna d’allora pro-
prio nella cittadina in cui era stata allestita la manifestazione di cui
ho parlato. Avevo in affitto una vecchia tabaccaia nella quale andavo
a dipingere. Un bel giorno avevo invitato uno di quei critici d’arte ai
quali in zona e ben oltre le amministrazioni danno incarico di orga-
nizzare mostre e avvenimenti culturali, un uomo di grande spesssore
al quale i miei dipinti apparvero troppo “puliti e precisini” per esse-
re inseriti in una qualsiasi manifestazione. Allora collaboravo con un
mensile satirico livornese e ben conoscevo le vicende delle teste di
Modigliani, credo che fu la memoria di quell’accaduto che mi suggerì
di fargli vedere due dipinti astratti, informi e ottenuti sgocciolando i
pennelli sulla tela. Il critico fu davvero entusiasta di quei lavori e mi
propose, qualora avessi eseguito una ventina di quadri come quelli,
di organizzarmi una esposizione in una importante galleria torinese.
C’era un solo piccolo problema, quasi insignificante, quelle tele le
aveva, secondo lui dipinte, a mio avviso imbrattate, mia figlia qualche
anno prima quando aveva undici o dodici anni.
Credo che certa gente, sia artisti che critici, abbiano operato, in parte
in autentica buona fede in nome della libertà, il vero problema era che
giorno per giorno, senza che se ne rendessero minimamente conto la
libertà li aveva imprigionati.
Credo che certa arte del novecento abbia contribuito ad innescare quel
processo mentale che ha portato a pensare, messaggio ampiamente,
ma spero non irreversibilmente passato, che la furbizia é ,un valore.
Da allora gran parte di ciò che é stato prodotto ha avuto il comune
denominatore della velocità e facilità di esecuzione, andando incontro
ad esclusive esigenze di mercato.
Questo tipo di arte ha contribuito a provocare l’inquina-
6
mento sistematico delle coscenze professionali, alla di-
struzione del senso civico ed ha impoverito il paese.
Ritengo che, al contrario, ricordando le nostre radici di legittimi pro-
nipoti di Giotto e di Leonardo, di Caravaggio, Antonello da Messina
e tanti altri, tenendo presente i valori del rinascimento, di sobrietà,
eleganza e bellezza, avremmo potuto sviluppare una modernità che
contenendo il seme della civiltà dei meriti, avrebbe potuto portarci
ancora una volta all’attenzione del mondo.
Per quanto mi riguarda, io, lontano da tutto ciò che é gratuito, refratta-
rio al fascino di qualunque facile guadagno, mai abdicando dalla ma-
nualità, continuai e continuo la mia strada, fatta di quadri a dondolo,
componibili o modificabili, strutture in equilibrio, che pur nella loro
evidente ludica ironia, mantengono le caratteristiche di tutta la mia
opera di campiture chiare, spartizioni nette, precise, perché credo nella
meticolosità del lavoro fatto di pazienza, oserei dire di abbandono alla
passione per ciò che si fa, in particolar modo quando si parla di arte.
Perché credo che il colore debba essere rispettato e tramutarsi in ar-
monia ed eleganza, attivare il godimento di guardarlo, sollecitare infi-
ne quei brevi istanti di gioia spirituale che fanno sentire in comunione
con l’universo, pur essendo impensabile di essere quali maestri del
cinquecento, poiché nulla é come allora ed é normale che il nostro
gusto e le nostre sensazioni siano espresse tanto diversamente, ma con
un bagaglio che io definisco morale e civico, appartenenza e memoria
storica. Utopia di un mondo pulito.
Leopoldo Terreni
www.leopoldoterreni.it