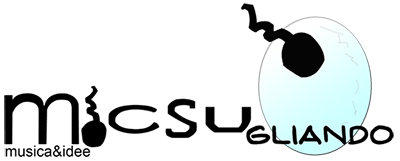1.
Con la voglia di scrivere che avevo, mi alzai senza far rumore. Sciolsi la tenda rosa sul letto e uscii fuori dal cottage di bambù, sedendomi in giardino. Mi ero abituato a un certo tipo di vegetazione, alle poche scimmie bianche che si avvicinavano, e alle lanterne del cortile. Erano gialle e rosse, come il tempio di Brahma, e ne avevo comprate due uguali. Scrissi sul mio quaderno che cercavo di portarmi via l’India in ogni modo possibile, e poi non annotai nient’altro per l’intera giornata. Mi capitava spesso. Restai a girovagare fra le palme per qualche tempo, poi lei si svegliò e ce ne andammo in sala da pranzo, dall’altra parte della tenuta.
Servivano le portate su un tavolo nero, il pollo nei tegami di rame, il riso e le verdure in ciotole di ceramica. Nessuno osava servirsi del pesce nel vassoio grande, sembrava ancora mezzo vivo. I tedeschi parlavano dietro di noi e ogni tanto coglievo qualche parola nel mucchio, cercando comunque di apparire distratto, così da non farmi coinvolgere in nessuna conversazione. Appena finito volevamo andare in spiaggia, ma non col solito taxi. La reception, in ogni caso, era vuota: la tenda arancione si muoveva appena sotto il refolo del ventilatore, la luce del corridoio era spenta. Chapora Beach distava dieci minuti a piedi, se non si decideva di prendere la via panoramica verso il Forte.
2.
Il Mare Arabico era calmo. Passeggiavo sulla costa, fra le palme d’acqua, e lontano vedevo l’altra sponda del fiume coperta di vegetazione, e qualche barcaccia di pescatori. Non c’erano più di venti stranieri, compresi noi, e nessuno aveva allestito stabilimenti balneari, bagni pubblici, chioschi per il ristoro. Tutti quelli che avevano bisogno di un po’ d’ombra stavano sotto i minuscoli gazebo di foglie secche. In un anfratto fra gli alberi c’era la riserva di tronchi, attrezzi, balle di vegetazione, sacchi e reti, e io me ne stavo seduto in attesa che qualcosa accadesse. Eppure, gli uomini del posto ci guardavano con gli occhi vuoti, come se potessero passarci attraverso. Allora, non riuscivo a venirne a capo. Piano piano, il mare brillava sempre più forte avvicinandosi al tramonto, mentre aspettavo il suo ultimo bagno prima della sera. Usciva in mezzo alle onde con un bikini colorato, a passo svelto, e mi si buttava accanto sull’asciugamano. Adoravo allo stesso modo questa sua abitudine e come la colpiva la luce rossa, radente. Ero sempre pieno di pensieri, di quelle espressioni mancate della gente, e mi chiedevo se avrei finito per capire o no. Ciò nonostante, ero sereno, e più di una volta ricordavo la statua dorata dell’hotel: una rana in preghiera, col muso sorridente e le gambe incrociate, davanti a un laghetto artificiale di fiori di loto. Mi proposi di salutarla il giorno dopo, prima di lasciare definitivamente la regione e andare a Morjim.
3.
Morjim ospitava una famosa riserva di tartarughe marine, ma quella parte di spiaggia ci era preclusa: le autorità impedivano l’accesso per paura di disturbare la deposizione delle uova e l’alimentazione degli animali. Per il primo pomeriggio, di comune accordo, ci eravamo accomodati al Boom Shack, e avevamo prenotato un taxi che ci avrebbe portati al nuovo hotel subito dopo cena. Ci trovavamo, in quel momento, in un tratto di costa dichiarato non commerciale.
Come al solito, dopo il bagno, mi ero perso in una camminata, sfruttando il fondale bassissimo. Arrivai fino all’insenatura dei pescatori, molto più numerosi di quanto mi aspettassi. Quelli che mi videro si voltarono, rimasero fermi qualche secondo, poi continuarono a lavorare intorno alle reti della Jaiwanti. Non chiesi loro niente: fissai il colore della pelle, i vestiti delle donne, le baracche di palme e i cani. Rimasi immobile per minuti interi, poi, come ero venuto, andai via, e mi sedetti di nuovo al bar.
Morjim aveva un gusto occidentale. Negli stabilimenti e nei chioschi rivedevo Vada, e la somiglianza sarebbe stata ancora più impressionante se non fosse stato per la vegetazione. Trovavo altri rimandi, comunque, nei motorini colorati e nelle bancarelle, che vendevano gonfiabili, palloni da calcio e infradito. A cena, vicino al nostro tavolo, una chiassosa comitiva di russi tentò continuamente di offrirci da bere. In qualche modo, ci sentivamo ancora in Europa, complici anche i tedeschi di Assagao e le chiese portoghesi della regione. Persino il tassista conosceva l’inglese, anche se a stento: durante il tragitto volle sapere della nostra coppia e della nostra prossima destinazione. Era euforico.
Quando ebbe finito di complimentarsi, tutti restammo in silenzio. Io e Giulia parlavamo solo per stabilire i dettagli, o in casi di necessità o cortesia. Ci eravamo imposti una specie di voto, ciascuno secondo le proprie aspettative di viaggio.
«Do you look for?» ci chiese.
Non sapevamo cosa rispondere, e lui se ne accorse. Per togliermi dall’imbarazzo, gli dissi che si trattava di una semplice vacanza, un secondo viaggio di nozze fuori programma. Lui annuì, e non aggiunse altro. Quando mi avvicinai per pagare la corsa, con un’espressione seria ma compiaciuta, mi disse: «Yes, yes, go Varanasi.» Annuì ancora, mi ringraziò, e sfrecciò via tra le palme.
Quando toccai il letto di Giulia, e le coperte calde, mi addormentai.
4.
Arrivai a Vada, per la prima volta, a venticinque anni. Bastarono pochi minuti di macchina dalla casa dove trascorrevo le vacanze aspettando che Giulia mi raggiungesse. Era una giornata piovosa, e io cercavo un po’ di consolazione. La prima cosa che notai, e che mi stupì, fu la consistenza della sabbia sotto i piedi. Poi, la grandezza della spiaggia, e il mare limpido e calmo. Era l’opposto della riva di sassi di Caletta, minuscola e affollata, e su cui non si poteva camminare scalzi. In giro c’era pochissima gente.
Il cielo era scuro, ma non si decideva a piovere né a schiarire. Me ne andai avanti e indietro pensando a Giulia, alla famiglia che mi detestava a tal punto da impedirle di raggiungermi. Col passare del tempo, era diventato un chiodo fisso. Avevamo sofferto molto nel nostro primo anno, e io non sapevo cosa avevamo fatto per meritarcelo. Per la maggior parte del tempo, guardavo il fondale incredibilmente basso e soffice su cui passavano le onde minuscole, e stavo lì giusto per sentire l’acqua accarezzarmi le caviglie. Poi, mi misi a riflettere sui miei casi. Vada, allora, mi sembrava una conquista eccezionale, la prova che, con pazienza, avrei potuto sconfiggere la paura e il panico. Un giorno, avrei potuto viaggiare ovunque ed essere felice. Non desideravo altro. Forse, come nei grandi romanzi d’avventura, avrei finito anch’io col cercare qualcosa che non esiste.
5.
Mi capitava sempre di intendere il viaggio come un procedimento lineare, un percorso che comprende destinazione e arrivo. Se la buttavo sulla terminologia, pensavo alle implicazioni di andata e ritorno e alle compagnie aeree. Il concetto di ritorno, tra tutti quelli possibili, mi stava particolarmente stretto: presupponeva una casa, una dimora fissa, e una certa inquietudine. Per alcuni mesi, qualche anno fa, uscire di casa era diventato davvero difficile.
In matematica, avrei potuto dire che il viaggio è uno spostamento da un punto A ad un punto B, cioè un segmento di retta. Fantasticavo su questi dettagli mentre il treno ci portava da Bologna a Forlì. Non era nei piani, ma non avevamo trovato una stanza libera in tutta la città. Avevo scelto di andare a Forlì, a casa di Giulia, invece che tornarmene a Firenze, a casa mia. Finalmente, avrei visto la sua camera.
Il viaggio, quindi, doveva essere qualcosa di più complicato. Avrei dovuto dormire in una città sconosciuta e in un hotel che non avevo prenotato, per poi tornare a Bologna il giorno dopo, prendere un autobus e incontrare i suoi amici fuori dal centro della città. Era un impegno importante ma anche una grande fatica. Fatto quello, bisognava tornare a casa. La settimana dopo sarei dovuto tornare più o meno nei medesimi posti, per motivi di lavoro, e così in futuro, per la nostra relazione a distanza. Non avrei fatto altro che girare intorno al medesimo punto, scoprire cose nuove, in qualche maniera aprirmi a qualsiasi possibilità, persino ai peggiori imprevisti, e senza avere alcuna certezza. Odiavo questa situazione, e non sapevo neppure se sarei stato capace di sostenerla. Per non cedere alla paura, oltre che stringere la mano di Giulia, cercavo somiglianze assolute fra le varie città, per convincermi di non essere così lontano da casa. A conti fatti potevo avere ragione, molti luoghi della Terra si somigliavano.
6.
Mentre facevamo la spesa nella Conad di Forlì, poco lontano dall’obelisco illuminato di rosa, mi ricordai che a casa c’era Notturno Indiano da finire. Mi aspettava sul comodino. Era uno di quei libri strani, sospesi, e riuscivo a leggerlo solo di notte. In più, ero attratto dall’India e soprattutto dalla regione di Goa. Non c’era una motivazione specifica. Mi chiesi se era lì che volevo arrivare: in fondo, da bambino, avevo già sognato l’India di Alessandro, le steppe sconfinate dell’Asia, ed ero passato anche per Le Città Invisibili, proponendomi di portarlo con me.
Ad un certo punto il commesso disse: «Il latte è in offerta, ne pagate uno su due, andate a prenderne un altro.» Me ne incaricai io, e conclusi: visto che il viaggio era un eterno ritorno, un movimento continuo, il mio durava da più di 26 anni. Aveva avuto, questo viaggio, circostanze buone e cattive. Mi tornò in mente una considerazione di Giulia, durante un pomeriggio a casa mia: «Questa è la vita», disse. Si riferiva alla nottata appena passata: eravamo andati a ballare verso Lucca, ci eravamo svegliati all’ora di pranzo e avevamo fatto l’amore, finendo poi a parlare del più e del meno. Eravamo usciti alle tre per mangiare, e cercato un kebab in mezza città, perché volevamo assolutamente mangiare qualcosa di poco salutare. Quello sotto casa mia, ironia della sorte, era chiuso fino alle sei per tinteggiare la pareti.
Anche questo continuo girovagare, e questo pranzo così ritardato, in qualche maniera contraddiceva le mie ferree regole. Eppure, quando Giulia disse che era la vita, io sentii che aveva ragione: qualcosa di confuso, una specie di calore, mi si formò addosso, e qualcos’altro, dentro di me, si mosse. Dovevo essermi mosso anche nel sonno, con uno scatto improvviso. Giulia era sveglia e mi dava piccoli baci preoccupati. Era stato un sogno lucido, forse, simile alla nebbia dell’alba sul fiume sacro.
7.
A trentadue anni raggiunsi il Gange, nella provincia dell’Uttar Pradesh, dentro a una barca di pescatori. La guida che ci avevano consigliato non parlava molto: osservava la mia carnagione chiara, la cresta di capelli neri e i tatuaggi, e sibilava, di tanto in tanto, il mio nome. Quando pensò di aver raggiunto una buona pronuncia, cominciò con quello di mia moglie, che sedeva al mio fianco, in silenzio. Nessun altro turista era salito con noi.
I primi ad arrivare alla riva furono i pellegrini, quelli che si erano messi in viaggio giorni prima, e che sembravano migrare continuamente da tempio a tempio. Poco dopo, apparvero i ragazzi ai lavatoi. Il rumore della stoffa bagnata sulle pietre non aveva fine.
La guida sembrava incredibilmente annoiata, sul punto di addormentarsi. Continuò così per diversi minuti: sentivamo il suono secco dei panni, le litanie delle vecchie, i latrati dei cani, e nient’altro. Ero stanco, e sempre meno lucido.
All’improvviso, la guida disse: «Andrea, Giulia» e ci indicò un punto sulla riva. Era un crematorio. Un canto profondo avvolgeva il morto nelle fiamme, come se fossero la terra e il fiume intrecciati. In un inglese perfetto, l’uomo raccontò i maggiori riti indù, la rinascita del karma e il paradiso degli eletti. Aveva una voce suadente, che ci tramortiva. Non ci fornì alcuna informazione sulla città e sui templi, non si perse in aneddoti divertenti né ci dette consigli per alloggi e mezzi pubblici. Quando finì era mezzogiorno: centinaia di persone parlavano, gridavano, ridevano, si lanciavano nel fiume, cercavano uno spazio per lavarsi. Era un boato violento. Io mi riscossi.
8.
Dunque, quella era l’India autentica. A lei chiedevo una risposta: volevo sapere perché i miei genitori erano morti. Volevo capire se sarei riuscito a vivere con Giulia, nella stessa casa, dopo anni di incontri fugaci e città diverse. Il mio appello era sincero, disperato, e nel rumore assordante credetti di udire qualcosa.
Non avrei mai trovato la soluzione. Sarei tornato a casa, abituandomi a convivere con la donna che avevo scelto. Avrei comprato una macchina a metano. Sarei stato elogiato a lavoro. Avrei avuto altri attacchi di panico. Avrei dovuto discutere con i figli per il campo scuola. Il nostro cane sarebbe morto di vecchiaia. Avrei viaggiato così tanto da confondere la Tour Eiffel di Parigi con il Cristo Redentore di Rio. Sarei andato in pensione e avrei iniziato a coltivare un orto.
Ogni scalino di Varanasi mi diceva di accettare tutto: felicità e miseria, audacia e paura. Niente poteva essere definito se non attraverso il suo opposto. Avevo capito. Guardai Giulia, a lungo, finché non ci incrociammo. Io avevo occhi grandi e verdi, lei piccoli e castani. Portava i capelli ricci sempre sciolti. Di notte, il suo corpo era incredibilmente morbido e caldo. La mia pelle era più fredda, e mi spingeva naturalmente ad accostarmi a lei. «Parliamo un po’, ti va?» le chiesi. «Non vedevo l’ora» mi rispose. Ci sorridemmo.
Anche i bambini a riva, tuffandosi, sorridevano.
Azzurra Mangani