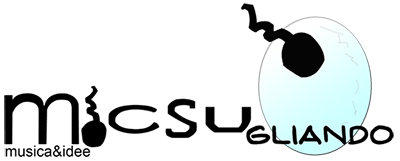Tornano gli Splatterpink (di cui avevo già recensito l’album Mongolflashmob ai primi di gennaio del
2015) gruppo bolognese di punta del neo hardcore italiano degli inizi degli anni Novanta.
L’occasione è la rieditazione del loro primo demo One uscito nel 1992 grazie alla Skank Bloc
Records (suppongo che prendano il nome dall’EP Skank Bloc Bologna degli Scritti Politti uscito nel
1978) che lo ha rimesso in commercio il 15 ottobre 2020 in una confezione in cassetta C30 con
copertina che riesuma l’estetica DIY dei gruppi post punk inglesi (fra cui appunto gli Scritti Politti) e
contenente le liriche delle canzoni (5 brani in tutto). La formazione è quella originale con Diego
D’Agata (basso e voce che qui assume lo pseudonimo di D.D. Bombay) motore del gruppo e unico
membro originario rimasto, all’epoca accompagnato da Metello Orsini (chitarra e cori) e dal
pirotecnico batterista scozzese Alaistar Brison. In questo primo lavoro emerge come l’estetica di
quello che lo stesso Elio Bussolino (storica firma di Rockerilla, Repubblica e Fare Musica) definì
“una delle più audaci e lucide espressioni della scena indipendente e alternativa nazionale” fosse
presente in tutte le sue componenti fin dall’inizio dell’avventura. Mi riferisco a quel progressive
punk tipico dei gruppi della SST che si liberarono dalla camicia di forza stilistica dell’hardcore
attraverso la sperimentazione di generi ibridi, la scrittura di brani più lunghi del solito minuto e
mezzo canonico, l’introduzione di elementi d’improvvisazione in forma libera e assoli prolungati.
Come nei loro modelli, l’estetica degli Splatterpink è nata e si è poi evoluta attraverso la
concisione dei Wire, la fusione fra i ritmi sbilenchi di Captain Beefheart e il funky operata dal Pop
Group e i deliri vocali dei Fall. Un basso pulsante e ribollente, una chitarra tutta brandelli di accordi
tanto asciutta quanto tozza e una batteria che è un generatore umano di breakbeat che sparge
sincopi e rullate di tom tom come schegge funky sono i biglietti di visita dei primi Splatterpink a cui
si aggiunge un pizzico di dadaismo d’avanguardia (simile a quello dei Lemon Kittens), dissonanze
jazzy (simili alla no-wave nevrotica dei Lounge Lizards) e soprattutto una sensibilità per l’attività
politica vicina ai centri sociali fucina e luogo d’incontro per una denuncia del capitalismo
proveniente dal proletariato delle tute blu. Quello degli Splatterpink è in sostanza un farnetico
scarno e insieme più analitico di ogni idioma punk fuso assieme allo spirito scapestrato di Zappa e
assolutamente lontano dall’epilessia reboante dell’hardcore ma invece acutamente descrittivo
dell’universo disperato degli adolescenti cresciuti in ambienti familiari ostili, rifiutati dai genitori,
claustrofobicamente immersi nelle loro fantasie erotiche o omicide, ignorati di una società che
non solo non li difende ma neppure li ascolta. I loro brani sono stazioni di un incubo permanente
in cui scorre l’hardcore d’assalto di Fra Di Noi nobilitato da un micro-assolo finale alla Fripp, il jazz
hardcore di Stai Nel Canile e Jazzy Splatter, l’hardcore caotico di Dromedario con pastiches vocali
alla Zappa e alla Bonzo Dog Band e infine V.I.P. ennesimo hardcore che parte come una variazione
del garage per sgretolarsi in forme disarmoniche che travolgono completamente le coordinate
della forma canzone e anticipano di ben un quarto di secolo l’arte di decostruire archetipi e generi
conosciuti attraverso strutture criptiche e nevrotiche come nei Mars Volta. Fin dagli esordi l’arte
degli Splatterpink ha avuto la funzione di tazebao e di tam tam della trasgressione pur riflettendo
le mutate condizioni di contorno e quindi riflettendo sull’essenza del mondo autoritario e
inflessibile in cui si trovano a dover vivere avendo poche o nulle possibilità di cambiarlo. La musica
degli Splatterpink trascende il discorso musicale: è un saggio sociale. E lo era fin dagli inizi.
di Alfredo Cristallo